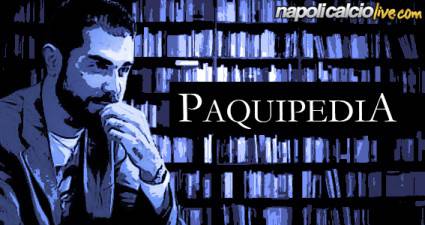
Ventitré anni. Più un mese e un paio di giorni. Se i miei calcoli sono corretti, leggerete questa storia esattamente ventitré anni, un mese e un paio di giorni dopo che è accaduta.
Innanzitutto, mi presento. Mi chiamo Daniel Fonseca, attaccante uruguaiano con un passato in maglia azzurra. Due anni, poco meno di sessanta partite, poco più di trenta gol prima di lasciare quella squadra di cui ero diventato il leader e che, per tentare di mettere in ordine un bilancio già a quel tempo precario, decise di piazzarmi al miglior offerente. Ma ai numeri dell’economia, preferisco i miei. Quelli da centravanti di razza; da uomo d’area di rigore che bissò le reti di Careca (non uno qualunque) nella sua ultima stagione azzurra e che, appena un anno dopo, concesse un bis in doppia cifra che, di lì a dieci anni, sarebbe stata vera rarità.
Potrei raccontare quei settecento e passa giorni all’ombra del Vesuvio, senza saltare il minimo dettaglio. Dando importanza perfino al numero dei respiri o degli “oh” di stupore. Non ne scorderei nemmeno uno. Ma temo non vi sia spazio. Esigenze editoriale. Righe troppo strette per comprimere due anni che non scorderò mai più.
Concedetemi, perciò, di raccontarvi un solo aneddoto. E, più che mai sarò preciso, perché gli eventi rari divengono indelebili pure per la mente più distratta.
Sedici settembre millenovecentonovantadue, allo stadio Mestalla va in scena la sfida tra Valencia e Napoli. Trentaduesimi di finale (concetto ormai desueto) di Coppa U.E.F.A. (un modo demodé di definire l’Europa League). In panchina Claudio Ranieri, in avanti io al fianco di Gianfranco Zola. Gli spagnoli attaccano e cercano di far male subito, ma noi teniamo duro e cerchiamo di far male ad ogni ripartenza. Si concretizza tutto al minuto ventuno, quando Zola mi lancia da metà campo e io, col sinistro in corso, la spedisco nell’angolo più lontano. Pareggiano loro all’inizio del secondo tempo ed è la più classica delle illusioni.
Spaccando il secondo, al minuto sessanta, segno di nuovo, sfruttando un lancio in profondità di Jonas Thern, quel ragazzo svedese con la faccia di idolo delle teen ager. Quattro minuti appena ed ecco che Policano, quello che somiglia un po’ a Rambo e un po’ a Thomas Millian, mi serve un assist a pochi metri dalla porta. Ancora un tocco di sinistro, ancora una corsa ad abbracciar compagni. Ancora il desiderio di buttarla dentro alla prossima occasione. Che arriva al minuto ottantasette, quando servito dalla sinistra, la spingo di piatto in rete. Bianca è la camiseta del Valencia, terrea è l’espressione di quella squadra in campo che assume sempre più i connotati della compagine amatoriale che si affronta a ferragosto. E già che ci siamo, mettiamo dentro pure il quinto gol. Il minuto è il novantesimo e approfittando dell’ennesimo svarione difensivo, in velocità penetro in area, con due finte metto k.o. portiere e difensori e poi l’appoggio dentro col destro che, fino a quel momento, mi era servito solo per tenermi in piedi. Valencia 1 – Napoli 5 si torna a casa ebbri di una felicità tanto rara quanto ingenua, frutto di numeri che per il calcio moderno hanno dell’ordinario ma che ventitre anni, un mese e un paio di giorni orsono, ti aprivano le porte dell’Olimpo del calcio. Un posto leggendario in cui mi sarebbe piaciuto farci giusto una scappata. Giusto per avere un aneddoto da raccontare al mio ritorno al San Paolo.






